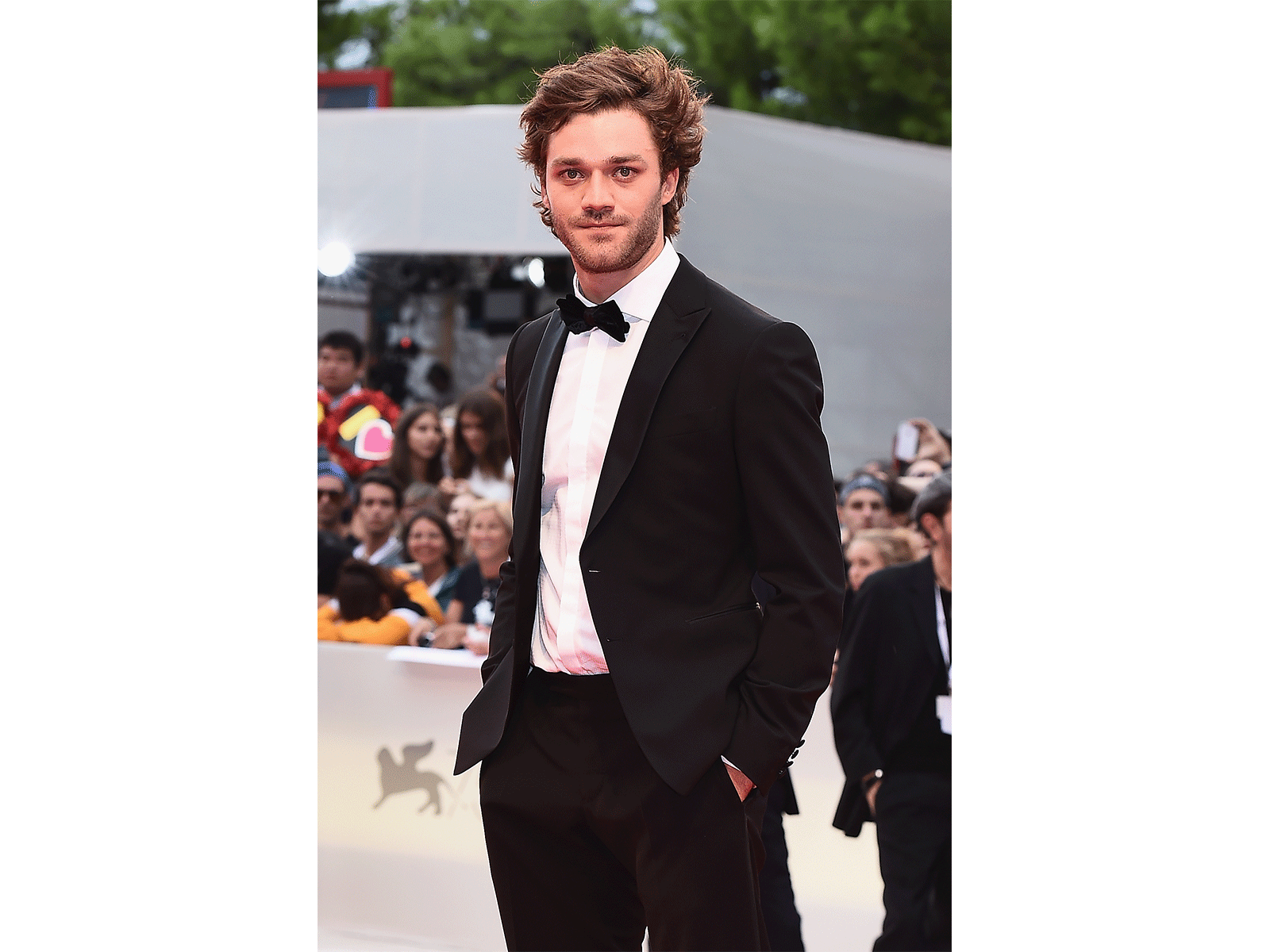Oltre la maschera: l’anima e le passioni di Lorenzo Richelmy
Diviso tra cinema e televisione (dove è stato uno straordinario Marco Polo), è ora tra i protagonisti, insieme a Sergio Castellitto e ad Anna Foglietta, de “Il talento del calabrone”, in onda su Amazon Prime Video. Lì, nei panni di un D.J., mette in scena la propria sfida contro una voce misteriosa: un’occasione per intervistarlo e scoprirlo a 360° in tutte le sue sfaccettature, passate, presenti e future.
Dietro alla maschera c’è l’attore, l’uomo, il funambolo, un’anima colta e a tratti bohémienne: Lorenzo Richelmy. Una storia tutta da raccontare la sua, e piena di (s)punti inediti. Spezzino di nascita, milanese d’adozione (trasferitosi recentemente in zona Navigli, vicino alla Barona), eppure “romano dentro” come sottolinea orgogliosamente, è uno di quegli interpreti, a 30 anni, ad aver già messo nel proprio carnet scalpi (artisticamente) importanti: da Matteo Garrone ai fratelli Taviani (Una questione privata), Donato Carrisi ne La ragazza nella nebbia, fino al successo internazionale, nella miniserie Netflix di Marco Polo, e in quella di Sanctuary, accanto a Matthew Modine.
Cinema, televisione, in Italia e all’estero, in cui è stato bravo oltremodo a sperimentare (in Vita spericolata di Marco Ponti), a inventarsi diabolico sognatore in Dolceroma di Fabio Resinaro, o rider acrobatico (in Ride di Jacopo Rondinelli). Un cittadino del mondo dunque, ma quanto mai attaccato alle proprio origini e alla sua famiglia di genitori teatranti, che lo hanno supportato a fare quel passo serio, lasciandolo libero di coltivare in egual modo la sua identità, piena di sfumature e riferimenti, superando un passato doloroso. Ora quel suo “volare sempre basso”, come spesso emerge nell’intervista, arriva invece a scalare un’ ulteriore vetta, come ne Il talento del calabrone, l’ottima pellicola di Giacomo Cimini, in onda dal 18 novembre su Amazon Prime Video. Una sorta di duello rusticano 2.0, che strizza l’occhio pure a Talk Radio di Stone, tra lui, rinomato D.J. milanese, e un misterioso mitomane, interpretato da Sergio Castellitto, che gradualmente produce la sua vendetta e lo tiene in scacco. Fino all’ultimo bit.
Cosa ti ha colpito della storia?
Di partenza sono sempre stimolato a fare qualcosa che si allontani molto da me. Vengo da una famiglia di teatranti, dunque ho una visione del mio lavoro precisa, che difficilmente si adatta alle regole del mercato, dove invece il carattere viene usato spesso da altri attori, che magari portano loro se stessi, camuffati, ma con quel tipo di energia. È già da un po’ che invece sto cercando di esplorare in maniera diversa, trasversale e il divertimento sta lì, come la lettura di questa sceneggiatura.
E qui sei un D.J.. che deve controllare una situazione inaspettata.
In maniera particolare sì. Non è solo un thriller, si parla di scontro generazionale, tra un professore universitario, colto, dal pensiero elevato, contro il ragazzino divenuto famoso grazie ai social. Pensare che io ho un rapporto davvero difficile con quel mondo, avevo bisogno di aiuto, l’ho ricevuto da mia sorella, che ha 17 anni.
Come mai?
Non amo per nulla il voyeurismo ostentato. Steph, da carnefice, diventa vittima a sua volta, e l’ho trovato affascinante. Era un modo per capire le ragioni, come attore, riguardo quello che puoi, e vuoi, fare, anche se in generale non devi mai odiare o giudicare il proprio personaggio: tu sei con lui, tu hai ragione. Oggi meno racconti e più attiri l’attenzione, abbracciare questo ruolo è stato come svuotare me stesso.
Si parla anche di bullismo, tema a cui ti senti particolarmente vicino, visto che l’ha subito.
È uno dei motivi perché ho accettato. Mi sono levato un peso a dir la verità, ma dovevo arrivarci pronto. Certamente usare esperienze personali, visualizzando i bulli delle medie, è stato importante, chiedersi il perché, cosa li aveva portati a essere così sadici.
Che risposte ti sei dato all’epoca, e come sei riuscito a metterti alle spalle tutto?
Mi trovavo alla fine delle elementari, inizio delle medie, ero grassoccio, mi prendevano in giro. Poi al liceo, quando sono arrivato, ho avuto la fortuna di essere solo, non avevo amicizie, feci tabula rasa. Non volevo più che succedesse, ma prima di superarlo, ho cercato di comprenderne le ragioni. Il bullismo porta sofferenza, traumi, è una rabbia sociale incontrollata, figlia dell’ignoranza, e la debolezza fa gola, unita al disagio di stare al mondo. Penso appartenga a tutti, in misure differenti, però avviene. Per me era dare un cambio alla mia vita, invece che raggiungere un canone che piacesse agli altri, dovevo rompere lo schema, c’è stato anzi un momento in cui non volevo mostrare le mie fragilità, le stesse che avevano permesso ad altri di prendersi gioco di me. Il cambio radicale, fisico, mentale, è servito successivamente a guardare, e farmi guardare, da una prospettiva totalmente nuova.
Quanta è servita la recitazione in questo passaggio?
Mi ha reso tutto più chiaro. Crearsi una maschera, inconsapevolmente ti può rendere forte, ma prima o prima sei costretto a togliertela, a mostrarti per quello che sei, ad affrontare il giudizio degli altri. Faccio un mestiere dove è normale essere visto anche per l’esteriorità, ma io ho sempre voluto fare l’attore, era un sogno, nonostante da ragazzo fosse complesso capire le regole che mi ponevano, se erano giuste o meno, andavo avanti col pensiero che le sovrastrutture sociali dominavano il mondo circostante. Nella trasformazione di cui raccontavo, ho attraversato la fase scalmanata, ma mai ribelle, stupida, cercavo il limite: nella recitazione mi divertiva da morire confondere le idee agli altri su di me.
Una parola per definire Sergio Castellitto.
Giovane. Improvvisa, studia, è genuino, fa trasparire un atteggiamento fresco, ero abituato ad altro, mi aspettavo un lavoro più strutturato, sa sempre sorprendere, d’altronde, ancora prima di incontrarlo, faceva già parte dei miei modelli di riferimento.
Chi sono gli altri?
Pierfrancesco Favino e Toni Servillo. Da loro ho cercato di rubare quando potevo, professionalmente parlando, per quello che hanno fatto, e continuano a fare, avrebbero meritato l’Oscar. Da ragazzino impazzivo per Tarantino e Fincher, Pulp Fiction, Fight Club, penso di averli visti una trentina di volte, poi, se andiamo all’estero, direi Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, o Denzel Washington, da piccolo mi piaceva, lo vedevo come un faro. D’altronde bisogna puntare in alto, e alzare sempre l’asticella, cercando di non essere mai etichettato.
Ne Il talento del calabrone la musica fa capolino, intervallando i momenti chiave. Per te che valore ha?
Ogni personaggio è una playlist, fa parte del mio studio. Amo ricercare canzoni, mi aiutano, sono fondamentali per costruire l’armo emotivo, e succede sempre prima di affrontare un ruolo. Personalmente adoro Philip Glass, dovrebbe far parte della cultura generale, chiederei di farlo sentire in radio, sarebbe come sentir parlare Alessandro Barbero di Alessandro Magno. Qui però, per “contrastare” le composizioni classiche, ho scelto basi da discoteca, non house, tipo Dubstep, drum and bass.
Tu suoni?
Ho avuto la mia piccola parentesi rock punk, facevo la voce in un gruppo, continuo a strimpellare la chitarra. Oggi sono fidanzato con una pianista, lei suona Bach in casa, a me basta poco per svenire dalla felicità quando la ascolto. Se da attore sono riuscito a coltivare una personale disciplina, altrettanto non posso dire di averla avuto per imparare a maneggiare davvero bene uno strumento.
Trent’anni di vita, una bella cifra tonda porta sempre a una serie di riflessioni: è successo anche a te?
Un attore non è mai autore di se stesso, salvo rari casi, stai sempre a lavorare in progetti collettivi dove però, quando accade, cerco di portare anche la mia visione trasversale. La sfida è cercare di non navigare nell’insicurezza totale che questo lavoro ti dà. Nel 2020 volevo tornare al teatro, il prossimo passo sarà lì, succederà a breve, me lo auguro, ma voglio parallelamente studiare, su come fare lo showrunner, lo sceneggiatore.
Sarebbe un modo per scomparire?
Paradossalmente sì, senza essere schiavo del mio volto. Coinciderebbe con una forma di maturità estrema. Interpretare qualcuno significa tornare a una dimensione quasi bambinesca, ecco perché per ora ho ancora voglia di giocare.
Nella tua carriera, spesso sei andato all’estero, ti immagini lì a sperimentare?
Come attore sì, ma se penso alla scrittura no. In America vado una volta l’anno, vivo belle esperienze, ma per una storia da raccontare serve conoscerla, e anche se ho viaggiato molto, da sceneggiatore mi vedrei in Italia.
C’è un un tema che ti appassiona oggi?
Una persona, semmai, che è scomparsa proprio qualche giorno fa: Israel Horovitz. Da anni la sua pièce teatrale, The Line, è andata in scena nei teatri off di Broadway: quattro attori, un palco, qualche linea a terra, e l’insegnamento di provare a tornare indietro, alle nostre radici. Non sono un fan della tecnologia, non vedo neanche di buon occhio questa transizione, fa sì che le generazioni si muovano meno.
Dunque meglio essere minimali che eccedere, è questo che intendi?
Stiamo diventando troppo barocchi, pieni di strumenti, quasi dei mezzi automi. Piuttosto che aggiungere, preferisco togliere, dire di meno: dovessi identificare uno scopo lo ricercherei nel diseducare, levarci dalle scatole dei pensieri che ci inquinano socialmente, e che non ci rendono più colti.
Parliamo di successo…
Mai avuto, e non lo cerco. La notorietà è arrivata, a livello internazionale, grazie alla miniserie su Marco Polo. Negli Stati Uniti l’accoglienza fu incredibile, io stesso fui contento di farla, ma da noi purtroppo non fece presa sulla gente, che mi fermava parlandomi solo de I Liceali. Un peccato, lì si celebrava un grande avventuriero, un grande italiano, lontano da tutti gli stereotipi di alcuni progetti odierni.
Non torneresti a fare un personaggio storico?
Marco Polo aveva un suo perché, forse direi Cristoforo Colombo, non sarebbe comunque facile, è un nome che divide ancora i nativi americani. Il rischio è non essere incisivi, ma se si potesse parlare di un mondo, e valorizzarlo, sicuramente ci penserei.
Se ti proponessero qualcosa legato allo sport, da praticante quale sei.
L’attore è un atleta, rimane sempre in allenamento, e io non sono da meno, non riesco a stare fermo. Ne Il talento del calabrone era necessario esserlo, facendo vibrare altre corde, la voce ad esempio, tenendola viva, quasi come uno strumento. Mi piacere correre, free running, e l’acrobatica di strada: da ragazzino, finito il Centro Sperimentale, ho iniziato a fare parkour, prima in palestra, poi all’aperto: è avvincente, a tratti doloroso (ride, ndr), quando atterri male.. Se dovessi scegliere punterei sulla danza, più che su un atleta.
Perché?
Vorrei fare un ballerino. Ne ho conosciuti diversi, e mi son reso conto che li invidiavo perché non dovevano necessariamente far leva sulla parola. Usano il loro corpo per raggiungere un senso alto. D’altronde l’arte può essere netta, radicale, alla Carmelo Bene, e la danza segue idealmente il medesimo percorso.. Mi viene in mente Pina Bausch, che nella danza ha rappresentato l’aspetto rivoluzionario, quanto Marlon Brando per il cinema: l’essenza della creatività sta anche nel svincolarsi dai proprio dogmi, e provare nuovi linguaggi. È quello che vorrei provare pure io.
Prima parlavi di italianità. Ad esempio Campari e Armani: per entrambi sei stato tra i protagonisti di un corto-evento. Qualche timore o fa parte del gioco?
Il fatto è che non mi prendo troppo sul serio, e quindi vivo le esperienze cercando semmai di assorbire le lezioni che possono darti. Non riuscirò mai a darmi importanza, sarebbe dannoso, c’è il pericolo di sentirsi arrivati, e non deve accadere. Di fronte alla copertina, all’aspetto glamour, patinato, mi sento sempre molto piccolo.
Che ricerca fai nello stile?
Penso si sia perso di vista l’uomo di una volta, un certo tipo di bellezza, vedi Marcello Mastroianni. Armani, ancora lui, è l’unico brand di moda, che negli anni non è mai sceso a compromessi, è sempre stato rigoroso, con idee alte. Ecco se mi devo vestire, preferisco abbracciare quel gusto, elegante, innovatore e conservatore.
Come ripartirai nel 2021: ti sei già dato degli obiettivi?
A marzo avrei dovuto cominciare a fare teatro, Macbeth di Shakespeare, diretto da Max Mazzotta, ero molto contento, ma purtroppo è stato sospeso, speriamo di ricominciare presto. Riguardo al cinema incrocio le dita, sarò il protagonista maschile per la nuova pellicola firmata da Roberto Zazzara, col quale ho già collaborato in un cortometraggio, e che negli anni ha maturato una grandissima carriera a Bollywood. È un horror, ma nonostante non sia un fan del genere, mi ci sono buttato subito. Le riprese dovrebbero cominciare a fine anno, è un progetto in inglese, prodotto dai francesi, girato in Italia. Da andarci a nozze insomma!
Ma alla fine Lorenzo come si carica davvero?
Grazie a un testo, che porto sempre con me: Limonov di Emanuele Carrère. Lì trovo quel tipo di coraggio che mi auspico di avere tutta la vita, magari arrivando a sporcarmi e buttarmi ulteriormente. Non vedo l’ora. Anni fa feci uno spettacolo su Philippe Petit, mi fece riflettere ulteriormente sul potere della concentrazione, Goethe disse a riguardo “Ogni volta che vedo un attore calcare le assi del teatro senza la concentrazione del funambolo, mi viene da piangere”. Sto attento a non dimenticarmelo mai, a essere presente a me stesso, tornando all’essenza delle cose, ad una forma quasi di religiosità, di paganesimo. Ma nel libro c’è una frase in verità: “Keep it real”, sì i soldi, sì il successo, ma non ti far fregare. Io che sono cresciuto in periferia, questa cosa non me la leverò mai di dosso.