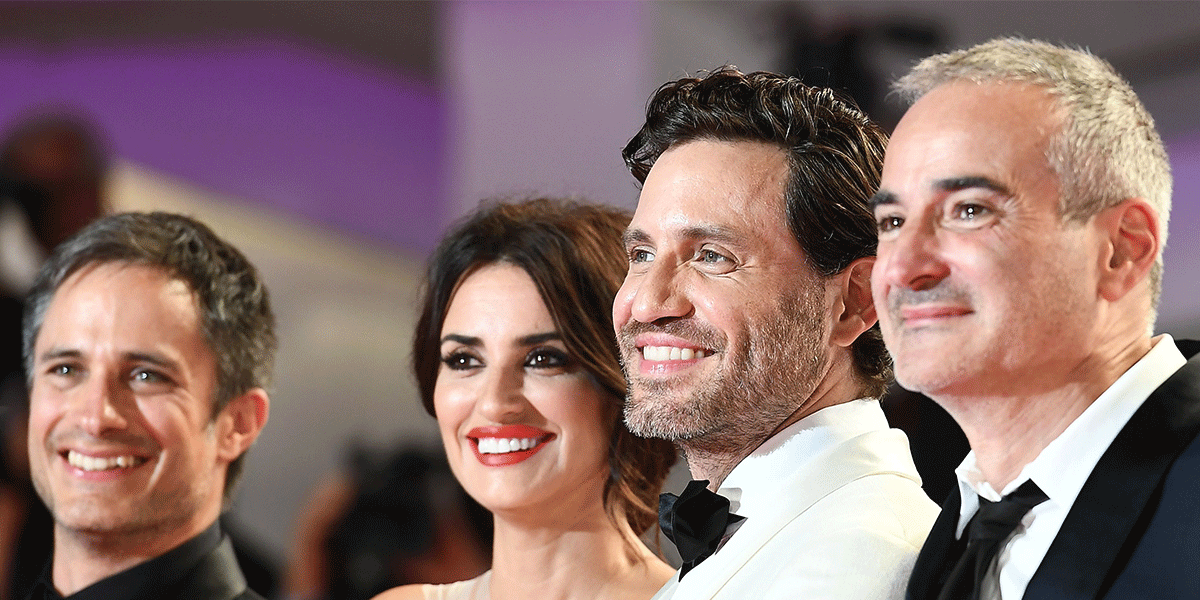Intervista a Olivier Assayas: “vi racconto l’incredibile storia dei Wasp Network cubani”
Olivier Assayas, regista degli acclamati “Personal Shopper” e “Sils Maria”, torna dietro la macchina da presa per “Wasp Network”, in onda su Netflix, la storia di un gruppo di esiliati cubani infiltrati nelle violente organizzazioni anti-castriste, con Édgar Ramírez, Gaël García Bernal e Penélope Cruz. Ce lo racconta in un’intervista esclusiva.
Colto, appassionato (anche di kung fu e d’Oriente), un vulcano creativo e d’esperienza, capace sempre di spiazzarti, pure telefonicamente. A incantare, è il caso di dirlo, è Olivier Assayas, regista francese tra i più amati, l’artefice di film, tra gli altri, come Summer Hours, Sils Maria e Personal Shopper, un narratore transgenerazionale, ma in egual modo innovatore nel portare avanti un certo tipo di stile, personale e ambizioso.
Padre sceneggiatore, madre fashion designer, la stessa che disegnò per la maison Hèrmes, l’autore e critico (lo è stato per i Cahiers du Cinéma) di Qualcosa nell’aria, adesso torna, a distanza di un solo anno dall’ultimo film (Il gioco delle coppie), raccontando una storia vera, ispirata dal libro-inchiesta di Fernando Morais. Quella di un gruppo di esiliati cubani, noto come ‘Wasp Network‘, da qui il titolo dell’omonima pellicola in onda su Netflix (fu in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019), capitanato da Gerardo Hernandez (interpretato da Gaël García Bernal), e di cui fece parte Rene González (Édgar Ramírez). Infiltrati nelle violente organizzazioni anti-castriste, responsabili di attacchi terroristici sull’isola, misero in atto una missione incredibile, che ora Assayas fa rivivere in una spy story piena di ritmo e pregio. Proprio come lui.
Cosa l’ha attratta maggiormente della vicenda?
Quello che mi ha interessato è stato proprio il fatto che non la conoscevo, è davvero straordinaria. Sicuramente è più conosciuta da voi, visto che una delle vittime di uno degli attentati (l’esplosione, nel 1997, di una bomba nel bar dell’Hotel Copacabana all’Avana, ndr) era proprio di nazionalità italiana (Fabio Di Celmo, ndr). Ero all’oscuro di questa “guerra” sotterranea tra cubani, infiltrati a Miami, e quelli dell’isola. Quando uno dei produttori, Rodrigo Teixeira, mi ha fatto poi leggere il libro da cui ci siamo ispirati, The Last Soldiers of the Cold War: The Story of the Cuban Five (“Gli ultimi soldati della Guerra Fredda. La storia dei Cuban Five”) scritto dal giornalista brasiliano Fernando Morais, è stato tutto molto chiaro: non era semplice narrativa, bensì un lavoro d’inchiesta straordinario, e mi sono veramente appassionato. È una storia che dice molto della politica anni ‘90, ma al contempo è ancora attuale nel presente, visto che le cose non sono cambiate così tanto tra Cuba e Stati Uniti. In più c’è un elemento umano affascinante formato dalle due coppie, le loro famiglie, i figli, l’amore che li accomuna, e li divide, il patriottismo, il senso del dovere.
Com’è stato girare a Cuba?
Non pensavo francamente che i cubani ci lasciassero così liberi, e invece si sono rivelati estremamente onesti nei nostri confronti. Alla fine abbiamo incontrato i personaggi reali, rintracciando i luoghi originali, avendo accesso ad alberghi, alle basi miliari. Dall’altro lato ci sentivamo un po’ “controllati”, lo ammetto, c’è stato qualche momento difficile durante le riprese, perché qualcuno sembrava più critico verso il progetto e non voleva aiutarci, altri, la maggior parte, ci hanno permesso di realizzare il film che volevamo.
Qui si parla anche di sacrificio per inseguire un ideale. Le è mai capitato nel suo lavoro?
Sono sempre stato un uomo indipendente, sia nel cinema, così nell’epica della vita. La difficoltà, talvolta, sta nel trovare la posizione giusta, e in questo senso mi sono sempre interessato ad argomenti diversi, alla politica contemporanea, osservandoli da punti di vista storici e differenti. Evidentemente, in una storia così contraddittoria, bisognava avere una certa apertura, una visione protettiva, quasi lontana.
I personaggi, interpretati da Penélope Cruz ad Ana De Armas, hanno un’importanza rilevante. Perché ama così tanto esplorare le donne?
Mi interessa lo sguardo femminile, da piccolo ne ero sempre circondato. Nel libro, però, erano quasi marginali, mentre io volevo metterli al centro emozionale. Raccontare le donne è qualcosa di estremamente affascinante, spesso, le dirò, quando inizio a scrivere, parto proprio da loro.
Parliamo allora di figure chiave che l’hanno segnata: chi troviamo in cima?
Tra i registi il più importante è stato Robert Bresson: lui ha davvero definito, in un modo speciale, la mia passione e fascinazione per il cinema, mostrandomi la strada nel capire degli aspetti che altri non erano riusciti a trasmettere. Non posso, poi, non citare Jean Renoir, Andy Warhol, l’artista più significativo per la mia generazione nell’influenzarci attraverso la relazione con la pittura, anticipando molte dinamiche, e Guy Debord che, come grande pensatore, è stato essenziale.
Lei riesce sempre a tirare fuori il meglio dai suoi attori, tra cui Kristen Stewart, che ha diretto due volte.
La adoro. Per me è veramente stato uno degli incontri più belli mai fatti. La cosa affascinante è il fatto che, nonostante abbiamo una differenza d’età, siamo cresciuti in mondi diversi e ci siamo approciati in modi diversi al cinema, a un tratto ci siamo ritrovati allo stesso punto. Tutto è sembrato funzionare in modo chiaro, e in maniera determinante. Io ho potuto offrirle la possibilità di crescere, in un momento in cui ne aveva bisogno, viceversa, lei, mi ha trasmesso una libertà unica, di intensità, sostanza, è una delle poche a dare originalità ai personaggi che interpreta. Ogni giorno “prego” per trovare una nuova idea e realizzare insieme un terzo film.
Nel 2010, la miniserie tv Carlos ebbe un enorme successo, che ricordo ha?
Non l’ho mai considerata come una serie innanzitutto, ma un film di 5 ore e mezza. Il mio modello, da una parte, fu il Che di Steven Soderbergh, e dall’altro Fanny&Alexander di Bergman, volevo creare una versione più condensata, ma interessante e piena di verità.
Ora, però, c’è un progetto nuovo per il piccolo schermo.
Svilupperò nuovamente miniserie tv, ma da otto episodi, ispirandomi a uno dei miei lavori, Irma Vep, uscito nel 1996. Gireremo a Parigi, quando le condizioni lo permetteranno, in inglese, e con un cast internazionale. Sicuramente sarà una bella sfida da affrontare.
Che ruolo ha avuto la musica, invece, nella sua formazione?
Importantissimo. Crescendo negli anni ‘70, la musica è stata qualcosa di potente, capace di cambiarmi la vita durante l’adolescenza, perché ciò che accadeva in quel linguaggio dava un senso diverso alle cose, era energia, attirava. Parlo del punk rock, del folk, di Nick Drake, Leonard Cohen, gli Amazing Blondel, e soprattutto Bob Dylan. L’ultima canzone ad esempio, Murder Most Foul, composta durante la pandemia, è di una profondità incredibile. Ognuno di loro ha influenzato il mio cinema, definendo poi chi sono.
Se parliamo invece di letture…
Hanno scandito la mia formazione, dalle note, ancora, di Robert Bresson, a Dante, l’Iliade, l’Odissea, Machiavelli, Mallarmè, sono tanti i testi. Ma c’è un romanzo in particolare, me ne avvicinai da adolescente, mi impressionò molto: è Omaggio alla Catalogna di George Orwell. Qui la differenza è ovviamente il modo in cui l’autore racconta in prima persona la guerra civile spagnola, mettendo in pratica una coscienza politica ed etica eccezionali, senza dimenticare la sua visione profonda, intensa, riguardo a quella attualità. La descrizione del periodo – inizia nel 1938 – è impressionante, gli appunti riguardo all’arruolamento nelle file del Poum, il fronte, il ferimento a Huesca, la drammaticità del conflitto, vivono di attimi eterni, grazie ad una lucidità appassionante. Qualche tempo fa mi è capitato di ritrovare la pubblicazione tradotta in francese, peraltro è una delle versioni più complete grazie allo scambio di lettere tra lo scrittore e Yvonne Davet, riscoprendo ancora una volta la sua esperienza rivoluzionaria.
Lei e la macchina da presa, che emozione c’è veramente dietro?
Quando sono sul set, in verità, ho l’impressione di fare sempre lo stesso film, come se il primo (Il disordine, ndr) fosse stato la tappa iniziale, e ogni volta sembra la continuazione del medesimo lavoro. È qualcosa di intimo, complesso, sento forte la necessità di dirigere, inventare, immaginare, provare a creare qualcosa di mai fatto prima. È un bisogno di ritrovare questa eccitazione vitale, che in fondo nessuno di noi dovrebbe mai perdere.