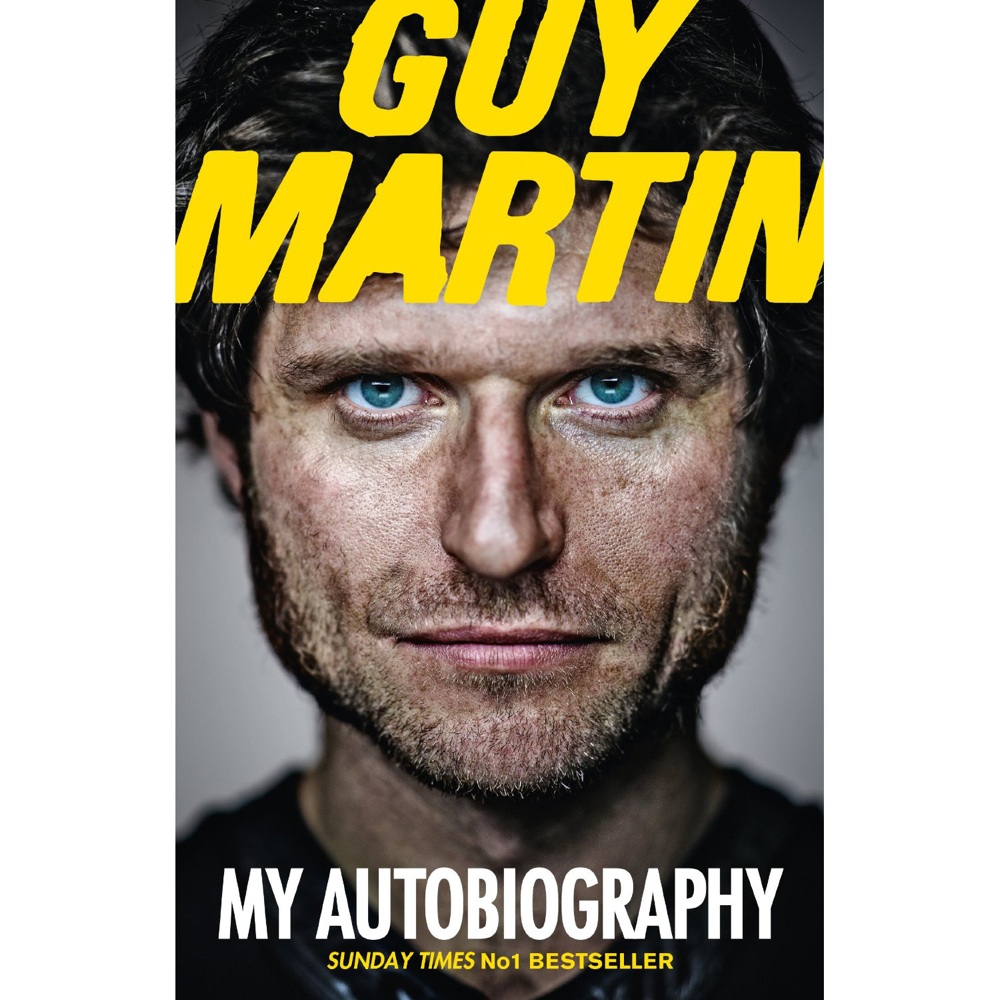Guy Martin, star della tv con l’ossessione di correre
La strana storia del campione di corsa su strada su due ruote
C’è una nuova parola d’ordine dal sapore nichilista che risuona sulla scena underground. La si vede cucita sui giubbotti di jeans, appiccicata sulle carrozzerie delle Harley, occultata sotto le tavole degli skate e ripetuta nei post sui social network: “Zero Fucks Given”, che tradotto significa più o meno “me ne sbatto alla grande”.
Un proclama privo di sfumature, 14 lettere di pura ribellione indirizzate, senza troppi giri di parole, all’Umanità. Ma potrebbe anche trattarsi di una delle toppe di cui sono costellate le tute in pelle del pilota di moto professionista-presentatore-Tv-meccanico-di-camion-ciclista-in-gare -endurance-di-24-ore nonché scapolo impenitente Guy Martin.
Lo notai per la prima volta nel 2006 in una foto che lo ritraeva mentre correva su una piccola pista nel nord dell’Inghilterra. Era concentratissimo, e sfiorava con il corpo lo spalto erboso. Organizzai un’intervista e mi trovai faccia a faccia con un personaggio già formato, con basette alla Wolverine e un sorriso largo come una fetta di cocomero – immagine che in otto anni è cambiata ben poco. Ai tempi, come oggi, faceva tre lavori diversi, uno dei quali consisteva nel raccogliere i bicchieri in un nightclub. Nel 2006 pensavo lo facesse per potersi permettere di correre sulla sua Suzuki 1000. Ora sono convinto che non sia capace di rilassarsi, e che il lavoro lo aiuti a chiarirsi con se stesso.
In quell’intervista, la prima pubblicata su una testata a diffusione nazionale nel Regno Unito, mi disse: «Nella vita faccio ciò che amo. Anche se dovessi morire, che importa? Ho una fidanzata. Siamo una coppia solida anche se non sono sposato, non ho figli. Magari lei o mia madre sentiranno la mia mancanza, ma… fanculo». Aveva 24 anni.
L’affermazione «Anche se dovessi morire, che importa?» scatenò polemiche a non finire. Ricordo che il padre di un’altra giovane promessa del motociclismo mi chiamò per dirmi che ero un irresponsabile a pubblicare certe cose. Ho sempre creduto che quel signore in fondo non volesse che gli venisse sbattuta in faccia la verità, ovvero, che di fatto stava finanziando il figlio perché partecipasse a uno degli sport più pericolosi, se non mortali, al mondo. E se altri tentavano di negare quel pericolo, Guy lo afferrava per la gola – e stringeva le dita.
Le gare di moto su strada, la categoria in cui eccelle, sono simili per molti aspetti ai campionati di MotoGP o di Superbike – le moto, le tute, i caschi sono identici – ma se ne differenziano per un aspetto cruciale: si svolgono su strada, non su circuiti ideati ad hoc. E le strade su cui si cimentano Guy e i suoi colleghi, per lo più in Irlanda e nell’isola di Man, non sono neppure i percorsi ideali. Sono strette, accidentate, con curve cieche affrontate a 280 km orari o più. A queste velocità sono strade straordinariamente pericolose.
I concorrenti nella MotoGP possono scivolare – come accade – a quasi 300 km orari, slittando sull’erba e sulla ghiaia prima di arrestarsi. I motociclisti delle gare su strada vanno a sbattere contro muri, lampioni, alberi. Non è la velocità a ucciderli, ma una brusca, violenta decelerata. La storia di Marco Simoncelli ci ricorda quanto sia rischiosa la MotoGP, ma i piloti su strada si muovono su un livello diverso. Ho assistito di persona a decine di gare su strada, dai muri e dalle staccionate che costeggiano il percorso, e ogni volta mi sento friggere il cervello di fronte a quello spettacolo.
I piloti di moto su strada in attività saranno al massimo 500 in tutto il mondo. Di norma 5 di loro – ben l’1 per cento – muoiono ogni anno durante una gara. Ogni anno! Mentre scrivo queste righe, la percentuale per il 2014 è già stata raggiunta, con due corse importanti (e pericolose) alle porte. Nei commenti riportati sulle pagine web dei quotidiani, questi motociclisti vengono definiti dei “pazzi ubriachi di testosterone” da salvare da se stessi. Molti dei lettori sfidano chiunque a prendere le difese di questo sport. Forse sarà uno sport indifendibile, ma a chi importa? Di certo non ai ragazzi che si iscrivono alle gare. Non lo fanno per i soldi. Dei 500 di cui sopra, sì e no 25 ci ricaveranno qualcosa di simile a un cachet. E di loro, 10 al massimo guadagnano più di quanto non farebbero gestendo un McDonald’s. Il resto non fa che spendere soldi, decine di migliaia di euro, solo per far parte del gioco. Ma il gusto di affrontare pericoli mortali è insito nel Dna di alcuni esseri umani. Chi ha evitato questa anomalia genetica non può, a volte non vuole, capire chi ne è perseguitato. Chiudete una strada agli impavidi patologici e loro ne troveranno un’altra in cui rischiare il tutto per tutto.
Il punto non è che Guy se ne infischia del pericolo: è proprio ciò che lo attrae. L’ebbrezza di essere a un passo dalla morte, il pensare che di lì a un secondo potrebbe essere finito tutto – e sopravvivere. La differenza tra Guy e il resto del mondo è che le conseguenze non lo spaventano. «Me ne sbatto alla grande».
Durante gli anni che ci separano da quella prima intervista, Guy non si è ammorbidito. Continua a vincere gare importanti, mozzafiato, letali. Nel corso della stesura di questo articolo è arrivato primo nel circuito più veloce del mondo, nel Gran Premio motociclistico dell’Ulster; in quello stesso giorno, un motociclista francese è stato portato via dalla pista con ferite che potevano costargli la vita. Ma se un tempo Guy riteneva, almeno secondo il mio punto di vista, che fosse nobile morire per conquistare il podio, oggi l’idea lo entusiasma meno. Eppure continua a correre più veloce che mai, in testa a una generazione di cui è stato in parte l’ispirazione.
Questo cambiamento nel suo modo di porsi potrebbe essere dovuto a una terza carriera, che Martin porta avanti in parallelo al motociclismo professionale e al lavoro di meccanico di mezzi pesanti: mi riferisco al ruolo di presentatore Tv in prima serata per la Bbc.
Tutto cominciò con un’intervista preregistrata, realizzata da un’emittente inglese per un servizio sul Tourist Trophy dell’isola di Man, in cui il nostro discettava sulla preparazione della perfetta tazza di tè e della scienza che si celava dietro quest’antica pratica. Quella prima apparizione fu intercettata da un regista televisivo, che divenne l’agente e il manager commerciale di Guy. Nel giro di pochi mesi, sul tavolo c’era un’offerta per un programma sulla tv nazionale inglese. Per tutti coloro che aspirano a sfondare nel mondo dello spettacolo, questo sarebbe stato l’apice di una vita di lavoro e dura gavetta. Ma Guy poteva permettersi di prendere o lasciare.
Iniziò le riprese nell’autunno del 2010, reduce da una frattura vertebrale, risultato di un incidente a più di 160 km orari sull’isola di Man, e con una vita privata ormai a rotoli. La sua ragazza, dopo aver scoperto una tresca, l’aveva sbattuto fuori di casa. Abitavano insieme nella fattoria dei genitori di lei, nel paesino in cui Guy era cresciuto. In più, si era appena disintossicato da una dipendenza da analgesici e veniva circuito da un losco guru religioso che stava tentando di plagiarlo, in un momento di grande vulnerabilità, per assumere il controllo delle sue finanze. La vita di Guy Martin sembra un copione di Hollywood – o una graphic novel dal retrogusto pulp in stile Diabolik.
In Tv, Guy si rivelò un talento naturale. Secondo l’idea dello show, The Boat the Guy Built, Guy e un suo vecchio compagno di scuola dovevano restaurare una chiatta in disuso, descrivendo il trascurato passato industriale della Gran Bretagna. Gli episodi raggiunsero uno share di quasi 8 milioni di spettatori e vennero riproposti nelle scuole come parte delle lezioni.
Guy venne poi soffiato da un’emittente inglese del digitale terrestre per una serie sulla rivoluzione industriale. A quel punto poteva permettersi di scegliere su quali progetti lavorare, ma non era interessato a una carriera televisiva e disse che era più felice nel riparare camion. Di nuovo, “me ne sbatto alla grande”. Al momento sta registrando la seconda serie di Speed, un programma di divulgazione scientifica di cui è il solo presentatore. Nella prima serie l’avevamo visto mentre cercava d’infrangere i record inglesi e mondiali di discesa dei toboga, velocità terrestre in bici, attraversamento di un lago in moto e volo mosso da energia umana. Sulla scia di un camion da corsa, portò una bicicletta a una velocità di 113 km orari. «È stata la cosa più pericolosa che abbia mai fatto su due ruote», mi confessò qualche giorno dopo.
Le persone che lo circondano, agenti, società di produzioni televisive e relativi registi e sponsor – inclusi i brand italiani Dainese per le tute in pelle e AGV per i caschi – sono spesso bendisposti ad accettare ciò che è meglio per Guy, ma il pilota resta sempre la gallina dalle uova d’oro. E se gli sponsor non gradiscono ciò che Martin serve loro sul piatto, be’, sanno già quel che devono fare. Guy apprezza il loro supporto e ormai ha difficoltà a spendere i soldi che guadagna, ma se uno degli sponsor dovesse mollarlo non perderebbe il sonno. «Me ne sbatto alla grande».
Personaggio complesso, Guy Martin è cresciuto in un piccolo paesino e abita tuttora a 20 km di distanza da dov’è nato. Vive da solo, e quando non lavora (registrando puntate per la Tv, partecipando alle gare, aggiustando camion – sì, sul serio!), lo si può trovare nella sua officina a costruire macchine o motociclette. Non ha una vita sociale, se si esclude una visita al suo vecchio amico per una tazza di tè di ritorno dal lavoro. Spende il proprio denaro in utensili, biciclette, motociclette e una Volvo vintage, con un moderno motore a 6 cilindri turbocompresso, un’auto personalizzata dall’apparenza innocua che corre più veloce di una Ferrari 458.
Nel 2011, a Guy fu diagnosticata la Sindrome di Asperger, sorta di autismo caratterizzato da una mancanza di empatia verso gli altri. Il che, si può ipotizzare, ha parecchio a che vedere con il fatto che sia single. Di certo non è per mancanza di attenzioni da parte del sesso femminile. Degli oltre 600.000 follower che ha su Facebook, ci sono migliaia di commenti lasciati da estasiate ammiratrici. Sebbene – sia ben chiaro – Guy non scriva post né si occupi personalmente dei siti o delle pagine dei social network che lo riguardano. Non spedisce neppure e-mail. Il suo cellulare è un Nokia 6310, uscito nel 2001.
Grazie alle gare su strada, Guy è diventato uno dei motociclisti più conosciuti al mondo e per anni la sua popolarità gli ha causato non poche seccature. Le corse su strada non sono la MotoGP. Le star non sono circondate dagli uomini della security a debita distanza dai fan. I paddock sono campi aperti. I team si raccolgono sotto tende fissate ad autoarticolati e i cacciatori di autografi si accalcano in attesa di arrivare fino a Guy. Specie durante il Tourist Trophy sull’isola di Man, un evento con cui Martin ha un rapporto di amore-odio.
In più, la Sindrome di Asperger gli combina qualche brutto scherzo quando si trova in mezzo a una folla desiderosa di catturare la sua attenzione. Guy ammette che gli passano per il cervello immagini folli e persino violente, mentre gli ignari simpatizzanti gli fanno la solita, banalissima domanda ascoltata migliaia di volte. Sente gli ingranaggi stridere. Il treno sta per schizzare fuori dai binari. Lui sorride, annuisce, concorda, ma sotto la superficie c’è un mare che ribolle. «C’è una domanda che mi passa spesso per la testa, qualcosa come: “Che succederebbe se spaccassi questa coppa sul cranio di qualcuno o dessi di matto per cinque minuti?”». E, di nuovo, il fatto che una star confessi questi pensieri – e nel pieno della sua carriera – è inusuale.
Lontano dai riflettori e dalle gare c’è la sua vera professione, quella che, dice, non abbandonerà mai: la manutenzione di autoarticolati. Esce di casa alle 6 del mattino, percorre in bici i 30 km che lo separano dall’officina, prepara i camion per la revisione annuale, poi pedala di nuovo fino a casa, a volte dopo più di 12 ore di lavoro. Se si sta preparando per una competizione ciclistica – gare endurance di 24 ore – spesso non torna a casa prima delle 23. Il lavoro in officina non è qualcosa cui si dedica una o due volte l’anno, ma un’attività che svolge settimana dopo settimana, se non è impegnato con le riprese o in gara. In due giorni di riprese può guadagnare l’equivalente di un anno di lavoro sui camion. E tra sponsor e bonus, figura già nella lista dei motociclisti inglesi più ricchi – tra le star del World Superbike e della MotoGP. Corre per la Suzuki, con sede nell’Irlanda del Nord, ma prende pochissimi soldi dal team. In cambio, non si presta alle pubbliche relazioni, che detesta. Se aggiungiamo i lucrosi contratti con la Tv e il successo dell’autobiografia – per due mesi in testa alla classifica dei best seller del Times, dopo aver scalzato Hillary Clinton – è evidente che l’ultima cosa di cui ha bisogno è lavorare, men che meno in un’officina su camion sporchi di grasso. Ma è il lavoro che ama. È nato, come dice lui, in un “posto di merda”, Grimsby, una cittadina portuale sulla costa nordorientale dell’Inghilterra. Una zona culturalmente stimolante tanto quanto può esserlo ficcare la testa nel water, ma Guy assorbe e raccoglie tutto ciò che può. Dopo aver completato la Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, una cronoscalata motociclistica su asfalto di ben 14 miglia, nella quale i partecipanti affrontano 156 tornanti per raggiungere un’altitudine di 4.302 metri (la gara da cui sono tratte queste foto, ndr), Guy si è seduto da una parte e ha tirato fuori dalla tuta di pelle nera una copia di 1984 di George Orwell, accingendosi a continuare la lettura. Gli piace il rock alternativo e uno dei suoi cantanti preferiti è Ian Brown, ex Stone Roses. Non ha un televisore, non guarda le proprie serie, ma ama i film di Quentin Tarantino e di Shane Meadows. In un’intervista del 2013, quando venne chiesto a Tarantino come gli sarebbe piaciuto essere ricordato, il regista disse: «Come uno dei più grandi scrittori del secolo». Ho fatto la stessa domanda a Guy Martin e la risposta è stata: «Un bravo meccanico di camion e un tipo in gamba».
“Me ne sbatto alla grande”.
Traduzione_Silvia Montis