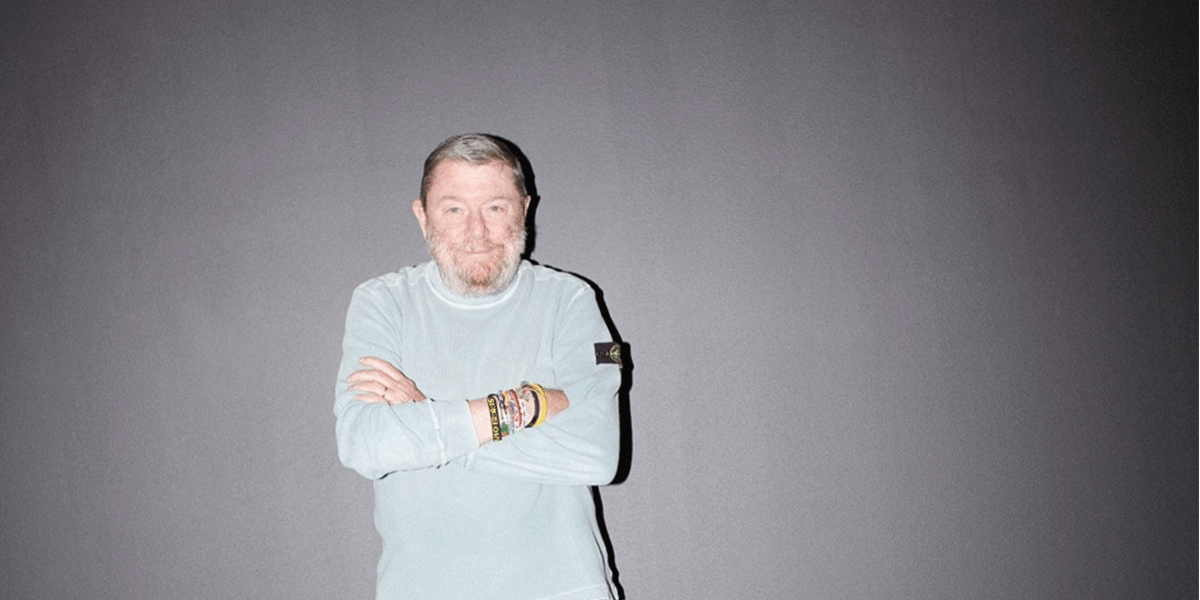Intervista a Carlo Rivetti, visionario fondatore di Stone Island
Abbiamo incontrato Carlo Rivetti, anima felice che ha creato l’identità di Stone Island. Senza mai guardarsi indietro.
Lui la chiama Stone. Continuamente. Come una figlia, una compagna, una parte di sé. E c’è da credere che sia un po’ ognuna di queste. Carlo Rivetti ha la gioia negli occhi. E non ha sogni nei cassetti, «perché li ho tutti in giro, i miei sogni li ho realizzati», dice mentre ordina il caffè. Il sogno di veder crescere un’azienda, Stone Island, che non cambiasse strada in base alle richieste del mercato, che non sentisse mai l’esigenza di dove, ad un certo punto, cambiare.
Qual è stata l’intuizione che ha acceso la scintilla, quella che ha dato il via alla storia di Stone Island?
Tutto nasce dall’osservazione di come i miei figli andavano vestiti a scuola. Mi sono accorto che indossavano quello che io mettevo per andare in palestra. Da qui la mia teoria: il mondo cambia dalle scarpe. Quando questa nuova generazione ha cominciato a mettersi ai piedi quelle che ora chiamiamo sneaker, ma che ai miei tempi erano le scarpe da ginnastica, mi sono detto: questi ragazzi cambieranno completamente il modo di vestire. Cosa che poi, effettivamente, è successa. Inoltre, come storia familiare, ho avuto una vita segnata dalla giacca formale. Condannata da quella linea di abbigliamento per bambini, Facis Junior, che produceva l’azienda della mia famiglia (la GFT – Gruppo Finanziario Tessile, ndr), già nel settore dell’abbigliamento: a partire dai 6 anni sono stato costretto a indossare blazer blu, cravatta e pantaloni grigi per andare a scuola. Tutti i giorni. Poi, allo scoccare del 14esimo anno — la linea era dai 6 ai 14 — pensavo di essere finalmente libero, insieme alla conquista del mio primo motorino. Di aver raggiunto un’indipendenza nel vestirmi. Ecco, in quell’anno lanciarono la linea Facis 20 anni.
Nessun accenno di ribellione? Stenterei a crederle se mi dicesse che si è rassegnato così facilmente.
Ma scherza?! Sulla mia ribellione al formale ho costruito un’intera azienda. Mi sono ribellato, sì. Ma solo dopo essermi laureato, con la sorpresa di mia madre, tra l’al- tro, che mi disse «Non ci avrei mai creduto». Entrai così in azienda e mi resi conto che guardava solo all’abbigliamento formale. Ma a me piaceva vestirmi in un modo diverso. Ho ancora negli occhi un ricordo, sa. Lavoravo da meno di un anno, riunione convocata per un sabato qualsiasi del mese di luglio nei primi anni 80. Non le dico il caldo. In un momento di particolare creatività mi presentai con una polo, blazer blu e un paio di jeans. Entrai in sala riunioni ed ebbi addosso 12 paia di occhi con un’espressione mista tra stupore e terrore. Da qui nasce questa passione di un altro stile, uno stile diverso, e riuscii a teorizzare la nascita della GFT Sportswear, terza referenza aziendale dopo l’uomo e la donna. Nel 1993 la rilevai con mia sorella, distaccandomi dal colosso GFT e diventammo così una piccola media impresa emiliana. Ma perlomeno facevo quello che avevo ben chiaro in mente. Con qualche inciampo, ovviamente.
Ha mai fatto delle scelte sbagliate?
Dunque. Dal GFT ereditai qualcosa come 14 marchi. Ma la mia strategia era un’altra. In tempi non sospetti avevo già scelto: volevo rimanere solo con Stone. Così ogni anno, mentre l’azienda cresceva, tagliavo uno dei rami. In modo scientifico, ci crede? Le scelte sbagliate ci sono state. Gli errori sono stati dettati dall’impulsività, ma a un giovane era pur concesso. Però, quando sei un imprenditore in questo Paese, devi essere un inguaribile ottimista e dagli errori cercar sempre di imparare. Per esempio, quando sperimentiamo qualche nuovo trattamento, che sia una tintura, un tessuto, infiliamo il prodotto nelle macchine che poi una volta chiuse diventano custodi della trasformazione. Aspetti come un padre fuori dalla sala parto, e poi ti trovi tra le mani un eccezionale errore. Che a volte è anche difficile riprodurre. La creatività nasce anche da uno sbaglio. Confesso che a me piace, veda un po’ Massimo Bottura e il celeberrimo episodio di quando, per errore, rovesciò una crostata al limone poco prima del servizio. L’effetto lo colpì talmente che lo chef decise, da quel momento e per sempre, di servire così il suo dessert. (Oops! Mi è caduta la crostata di limone, ndr)
E invece le scelte giuste, quelle che hanno davvero svoltato il brand, in cui credeva fermamente?
Una delle scelte giuste è stato anche forse l’unico grande momento di solitudine della mia vita. Quando ho scelto di vendere C.P. Company. Vedevo arrivare una crisi devastante, e mi rendevo conto che l’azienda non poteva sopportare e supportare entrambi i brand. Sapevo che quello su cui dovevamo puntare era Stone. «Fai la figura del matto», mi diceva mia moglie, la mia parte sana. Ma ebbi ragione. Poi c’è stato un altro punto di svolta. Nel 2012, in occasione del 30° anniversario dell’azienda, alla Stazione Leopolda di Firenze. Era un momento molto particolare, eravamo appena stati colpiti dal terremoto. Per la prima volta ci siamo guardati tra di noi, dentro di noi e mi è venuto da urlare: «Cazzo, siamo un’azienda seria!». Non c’era mai stato il tempo, né l’occasione, di guardare a quello che in 30 anni avevamo fatto. Uno straordinario patrimonio.
Cosa c’è in Stone Island che fidelizza con questa passione il cliente?
Il prodotto, 37 anni di integrità. Di onestà, di rispetto del dna, di non voler per forza piacere a tutti a tutti i costi, di non cambiare lingua a seconda dei momenti. Il mercato come sa oscilla, io ho scelto fin dal principio di non corrergli dietro. Sarei sempre e comunque arrivato in ritardo. Ho scelto di proseguire dritto, lungo la nostra strada. Proprio stamattina mi hanno chiesto «Come ha fatto ad arrivare con questa intensità ai millennials?». La verità è che non siamo stati noi ad andare a prenderli, sono loro che sono arrivati da noi. Questa nuova generazione è attenta approfondiscono, conoscono la storia. È questa la cosa che mi dà più soddisfazione e certezza verso il futuro.
Di Stone ci si innamora, insomma…
In un certo senso sì. Chi si avvicina al nostro brand o si innamora o ci abbandona subito. Pensi che un giorno, sempre nell’anno del trentennale, mi chiamò il mio responsabile Germania e mi disse: «Carlo, guarda. C’è qui un signore disperato perché non trova il libro dell’anniversario». Mi informai su chi fosse, era un fotografo di fama internazionale. Settanta ragazzi sotto di lui, un headquarter piazzato in un aeroporto dismesso dell’esercito americano. Uno studio fotografico enorme e una casa altrettanto grande che occupa una delle due torri. Volai da lui. Voleva farmi vedere il suo guardaroba. Un armadio di 400 metri quadrati in cui ho rivisto tutta la mia storia. 1.200 capi di Stone divisi per occasione d’uso. «Perché?», gli chiesi. Rispose: «Io riconosco l’onestà intellettuale del marchio. Vedo sincerità». E mi mostrò il suo primo capo acquistato, era un costume da bagno comprato in saldo, perfettamente conservato. L’avrei baciato dall’emozione.
È un collezionismo che forse è più da vivere che da mettere in mostra, direi.
Sì perché i nostri clienti, i fidelizzati, come li ha chiamati lei prima, non comprano i capi di Stone per poi chiu- derli in una teca e metterli in bella mostra. Li vivono, li raccontano, li studiano. Conoscono i particolari della lavorazione e riconoscono i pezzi vintage, quelli che non sono più in produzione. Un giorno entra un signore qui in showroom con un parka del 2008. Non ce ne sono più in giro. Subito gli andai in contro e gli chiesi di vendermelo per riportarlo a casa e infilarlo nel mio archivio. Ha accettato, e in cambio si è portato via due pezzi nuovi dicendomi «Ci rivediamo tra dieci anni!».
Quanto è importante la ricerca, la sperimentazione? Ha investito molto sul fattore umano. Dove va a prenderli questi creativi?
Beh, un po’ ne approfitto perché insegno al Politecnico di Milano che, come può immaginare, è un bacino importante in termini di creatività. In più devo dire che la cresciuta visibilità del brand, dell’azienda, ha suscitato interesse. Sono molti i ragazzi che ci scrivono perché vogliono far parte del team. Inoltre ricevo storie meravigliose. Mi ha scritto recentemente un ragazzino inglese raccontandomi che sei anni fa ha comprato una giacca di Stone usata, l’ha rimessa a posto, poi rivenduta e comprate due e via dicendo. In pratica era diventano un reseller. Mi ha scritto perché voleva ringraziarmi: con il guadagno si è pagato l’Università.