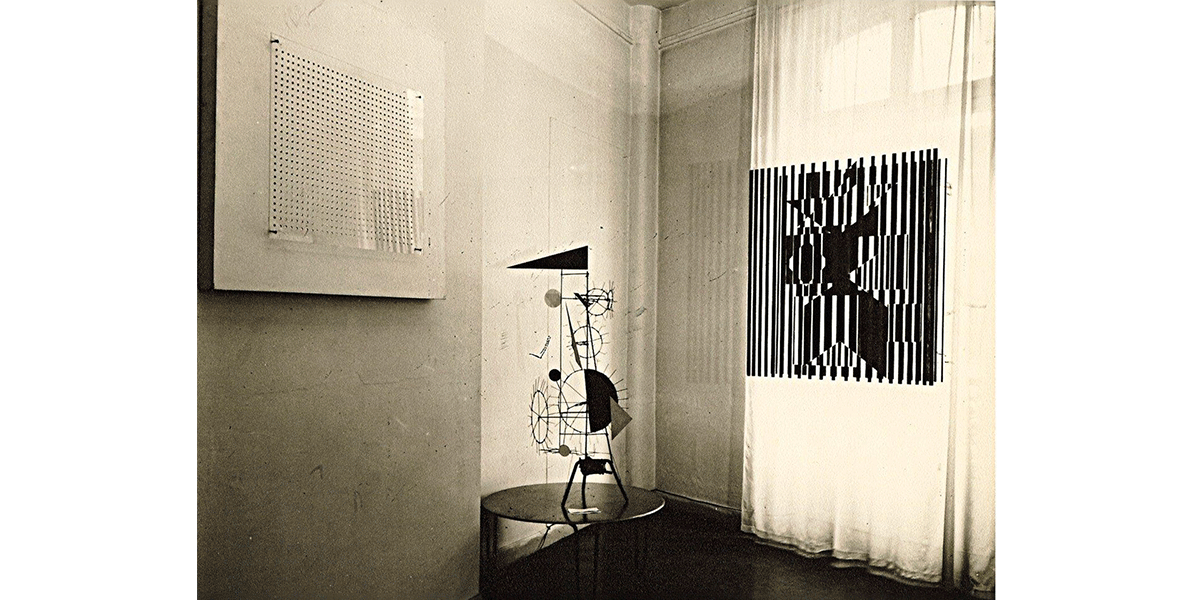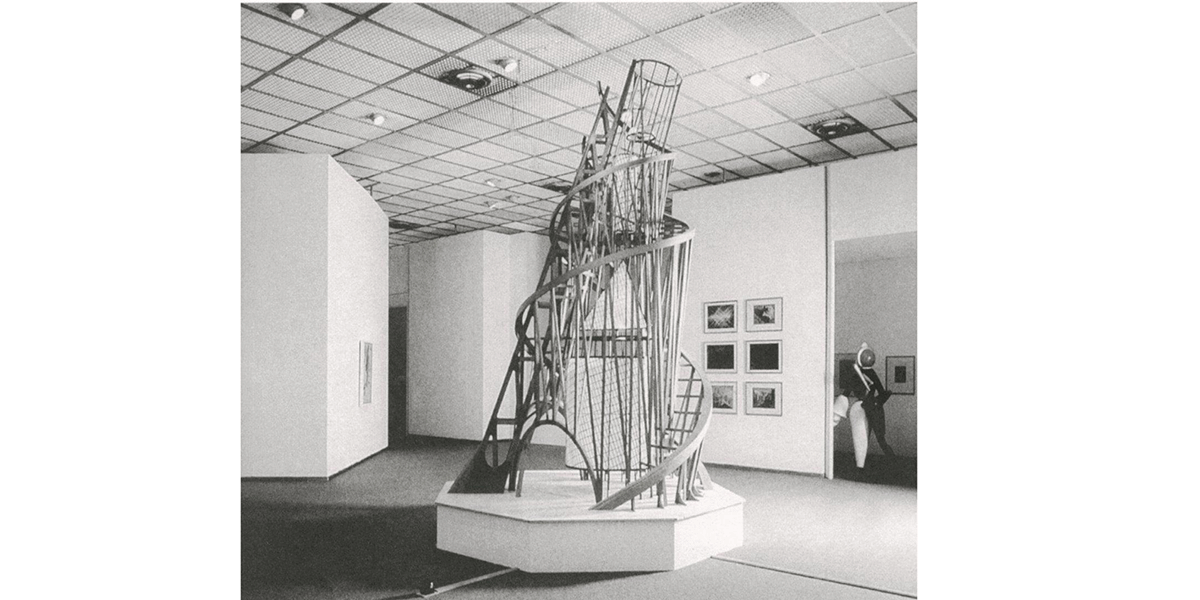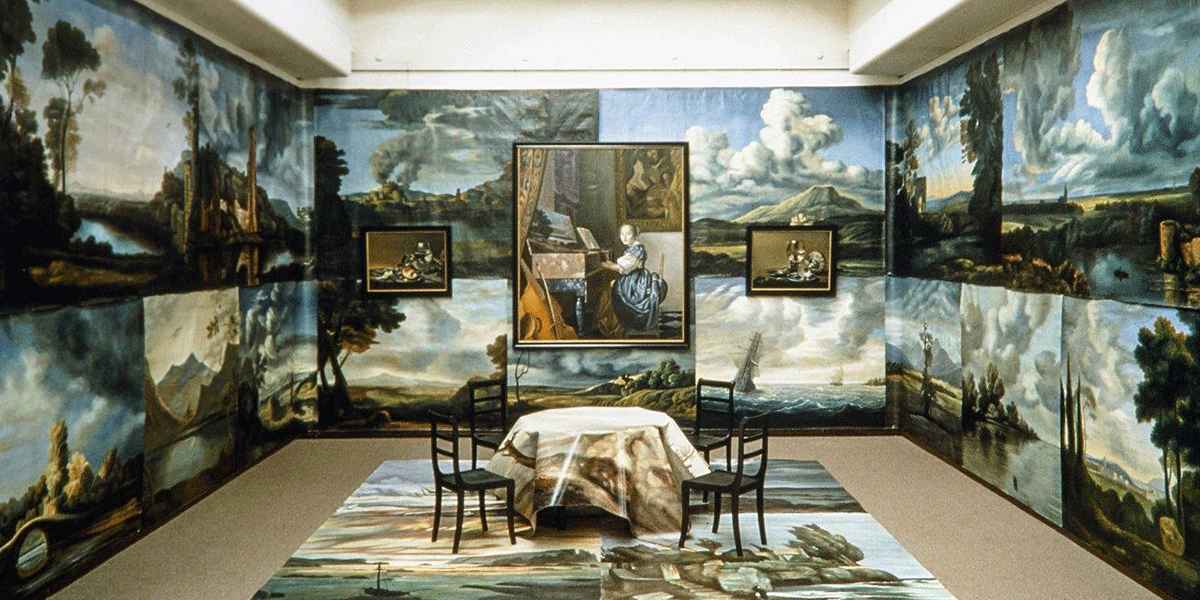Le cento mostre d’arte che rivoluzionarono il mondo
Un libro raccoglie le esposizioni epocali che tracciarono i nuovi percorsi dell’arte moderna e contemporanea. Sconvolgendo prospettive e pensieri.
1953, Palazzo Reale di Milano. Guernica di Picasso fu esposta a cielo aperto nella Sala delle Cariatidi sventrata dalla guerra. Una decina di anni dopo, alla Biennale di Venezia del 1964, la Pop art sbarcò sulle navi della Marina americana in Laguna e travolse il mondo dell’arte.
Ed è proprio quel verbo, “travolgere”, il filo rosso che unisce Le cento mostre che sconvolsero il mondo, raccolte certosinamente da Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli dal 1863 al 2000 (24Ore Cultura). Gli eventi epocali che hanno rivoluzionato la storia di quello che definiamo con un po’ di puzza sotto il naso artworld. Gli autori ne hanno raccolti cento, come le tre cifre viola metallizzate stile Balloon Dog di Jeff Koons stese a caratteri cubitali in copertina. Un libro da leggere come un romanzo appassionante. Lasciandosi trasportare in fratture romantiche del passato, oramai quasi sparite, sopraffatte da un sistema dell’arte sempre più schiavo di logiche finanziarie e speculative.
Come quando Monet, Renoir, Degas e compagni en plein air, approfittando del trasloco dello studio fotografico dell’amico Nadar, alle 10 del mattino del 15 aprile 1874 inaugurarono la prima mostra Impressionista, spalancando le porte all’arte Moderna. Alla vista di quelle 163 opere invase di luci fresche e azzurrine, il critico Armand Silvestre scrisse che «una luce bionda le inonda, e tutto è gioia, splendore, feste di primavera, sere dorate, meli in fiore…». O quando a Monaco di Baviera, nel dicembre del 1911, si tenne la prima mostra del Blaue Reiter, il Cavaliere azzurro. Nome ai confini del magico, scaturito dall’incontro di Vasilij Kandinsky e Franz Marc seduti al tavolino di un caffè sotto il pergolato del bucolico paesino di Sindelsdorf in Germania. «Entrambi amavamo l’azzurro, Marc i cavalli, io (Kandinsky) i cavalieri. Così venne fuori da solo». La valenza simbolica delle due figure si spande. Nell’azzurro, colore cardine della spiritualità. E nel cavaliere, immagine della vittoria del bene sul male. 43 opere per 14 artisti, con un fine comune. «Mostrare la molteplicità delle forme che assume l’anelito interiore dell’artista», nel quale il colore, osserva Kandinsky, è «un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima», insistendo sulla «musicalità dei colori necessaria perché l’arte diventi astratta». Pietre miliari. Punti cardine, di rottura. Due “prime” che stravolsero l’intero teatro dell’arte. Come molte delle rassegne che costellano il volume.
Da quel mitico Salone des Refusés del 1863 a Parigi, in risposta a quello Ufficiale con la Colazione sull’erba di Manet in scandaloso trionfo, al corrosivo “mondo senza frontiere” di Philippe Vergne, tra Parigi e Minneapolis al principio del nuovo millennio (2000), quando ormai la poesia ha lasciato definitivamente il campo allo “spettacolo” fine a se stesso. Dove per “spettacolo” si intende l’estrema forma di relazione sociale in cui si celebra la gloria della mercificazione, limpido riferimento a La società dello spettacolo di Debord del 1967.
Constatata la spettacolarizzazione pressoché totale del sistema dell’arte, accompagnata al proliferare indiscriminato di rassegne di ogni natura, il curatore si chiese quale spazio ancora potessero ritagliarsi le arti visive. E in che modo la ricerca artistica si riarticolasse con la sottocultura del consumo e con l’industria del divertimento. La mostra (Let’s Entertain) scandagliò il ventaglio di risposte fornite negli ultimi decenni. Dalla miscela Fluxus anni sessanta agli anni del “liberi tutti” sul calar del secolo. Tra gli invitati “contemporanei” anche il nostro Maurizio Cattelan con il leggendario Stadium. Il lunghissimo calciobalilla la cui squadra, composta da 11 immigrati di colore, sfidava quotidianamente le compagini di visitatori. Una mostra profetica che puntava il dito su quello “spettacolo” che ancora oggi non ci dà tregua.
Il vanesio circo dell’art system, apoteosi della “business art” tanto amata e citata da Warhol nella sua Filosofia del 1975. Nulla è cambiato d’allora. Anzi, viviamo in balia di una diffusa ipertrofia espositiva di mostre per lo più inutili, senza una reale valenza scientifica. Eventi dove il pubblico è un consumatore. Un cliente da stupire, divertire, distrarre. E buonanotte alla densità critica, alla ricerca e alla conoscenza come strumento di crescita individuale e sociale. Meglio non assuefarsi a questi prodotti e farsi una vacanza con Cattelan ai Caraibi. Nel 1999 la sua fake Biennale: Blown Away VI, Caribbean Biennial. Annunciata a mezzo mondo, con tanto di presentazione stampa e testi critici. Riunì tutto l’egotico sistema dell’arte sull’isola di Saint Kitts. Ma non esisteva nulla. Nessuna biennale d’arte o simile. Solo una grandissima e goliardica messinscena. La maniera in cui Cattelan denunciava quel mondo dell’arte schizofrenico, oscillante tra mondanità effimera ed elitarismo concettuale, saturo di eventi autocelebrativi, sempre più assoggettato a logiche mercantili. Non rimaneva altro che il mare.